La Libreria “Voglia di Leggere” a Palermo ha ospitato la presentazione di “Tacito silenzio”, opera prima di Armando Caltagirone, autore originario di Grotte.
Pubblicato da Salvatore Sciascia Editore e impreziosito dalla splendida prefazione di Gaetano Savatteri, il libro è l’affresco dolente di una Sicilia tormentata dai conflitti di classe nel periodo storico della transizione dal sistema feudale a quello liberale e democratico, attraversata dalle pulsioni separatiste e afflitta dalla miseria delle classi sociali più deboli, motore trainante dell’economia povera dell’isola.
“Tacito silenzio”, dunque, segna il debutto letterario di Armando Caltagirone, classe 1955, una lunga carriera nella pubblica amministrazione maturata prima all’Ufficio IVA, poi in qualità di funzionario all’Agenzia delle Entrate e, successivamente, da direttore dell’Ufficio Legale della stessa.
L’opera presentata per la prima volta a Palermo è sorprendente, capace di conquistare, appassionare e rattristare al tempo stesso il lettore.
Profondo conoscitore della storia di Grotte, Armando Caltagirone ha voluto lasciare, attraverso le pagine del suo libro, una testimonianza ben dettagliata delle condizioni sociali ed economiche della popolazione locale nel periodo delle solfatare e della loro crisi, soffermandosi sugli effetti nefasti dell’arretratezza in cui la provincia agrigentina venne lasciata dopo la chiusura del polo girgentano.
In “Tacito silenzio” emerge il forte legame dell’autore con le proprie origini, richiamate attraverso la descrizione vivida dei paesaggi, degli odori, dei sapori e delle tradizioni del borgo di Grotte, il cui nome pare derivasse dal termine punico “Erbessus” che significava oscurità sotterranea.
Il piccolo centro fu in seguito chiamato “Mons Foveae”, ovvero abbondante di grotte.
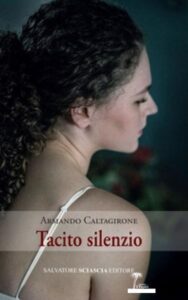
LA PRESENTAZIONE A PALERMO
Negli spazi della Libreria “Voglia di Leggere”, in via Antonio Pacinotti 36, l’autore ha dialogato con la giornalista Marianna La Barbera, direttore responsabile di “Report Sicilia”.
Al centro della presentazione, l’accurata descrizione sociale e politica del periodo storico in cui il libro è ambientato.
Attorno alla storia, ruotano interrogativi legati alla colpa, ai malintesi dell’amore, al suo senso e all’incidenza delle differenze economiche sui rapporti umani e sentimentali in una Sicilia lontana dalle rotte turistiche, dalle influenze della città e del progresso.
La prefazione di Gaetano Savatteri induce il lettore a scomporre la storia e lo invita a scandagliare una realtà ben più complessa come quella della Sicilia nel dopoguerra.
I protagonisti sono immersi in una realtà in cui fatica e miseria sono per i contadini e i minatori una condizione di vita perenne che trascina anche i loro figli e la discendenza.
Una vita segnata, priva di speranza e riscatto, al contrario di quanto accadeva per i borghesi, i nobili e il clero, intoccabili e ai vertici della società.
“Si tratta di un romanzo a strati – ha commentato la giornalista Marianna La Barbera nella sua introduzione all’autore – che mette in luce le criticità del passato della Sicilia del dopoguerra in parte immutate ancora oggi, in cui il determinismo sembra imperare”.
I fatti che hanno ispirato il romanzo sono realmente accaduti, l’autore con l’accuratezza di uno storico ha magistralmente montato elementi documentali ed elementi psicologici e umani attorno al tema dominante del libro: l’amore e la natura di esso in un periodo rivoluzionario per la nascita della Costituzione, per l’abolizione della pena di morte e il riconoscimento del diritto di voto alle donne. È il periodo di Giuliano e del separatismo.
LA TRAMA
La struttura di “Tacito silenzio” è quella tipica del romanzo: un delitto scuote la comunità per via dei due protagonisti Aurora e Ignazio.
Lei, figlia unica del borghese più ricco e in vista della città, lui figlio di un povero contadino conosciuto da tutti come il re di coppe per i baffoni alla Vittorio Emanuele.
Armando Caltagirone conduce il lettore all’interno di aspetti caratteristici della cultura del popolo siciliano come l’usanza di dare un nomignolo a ciascuno dei compaesani per via di un tratto fisico o caratteriale, quella ‘nciuria che sostituiva persino il nome vero.
Presi dal vortice della passione, i due giovani osano sfidare le barriere di rango e si abbandonano l’uno all’altra inconsapevolmente provocatori, rivendicando la vittoria sul preconcetto sociale che non consentirebbe loro di amarsi.
Aurora è vittima di un ingranaggio sociale in nome del quale sarà promessa al cugino per volontà paterna senza alcuna possibilità di rifiutarsi.
Ignazio, nullatenente e figlio di un contadino, è escluso dall’appannaggio di rango, che non gli riconosce di certo il diritto al sentimento.
E poi le sottili malelingue di Elvira e delle amiche di lei che lasciano intendere l’interesse di Ignazio per la roba e l’amara consapevolezza che il povero è amato per se stesso, un privilegio negato invece al ricco.
L’autore offre un ulteriore spaccato della Sicilia nella preoccupazione che Ignazio nutre per l’amico Bastiano, descrivendo la durissima realtà dei minatori nelle solfatare e adirandosi con il sistema: l’unica soluzione è emigrare, lasciare gli affetti e la terra natia per non morire come le bestie.
Quando ci si sente da meno la linea di confine tra amore e rabbia diviene sottile, così pian piano si insinua in Ignazio il tarlo del dubbio se Aurora lo ritenga interessato solo alla roba e dunque meschino.
Trattiene l’istinto di picchiarla per ricordarle chi comanda e scarica il livore contro Elvira e le amiche di lei all’inizio, ma quando la supremazia del maschio emerge in lui l’epilogo è inevitabile.
La violenza fisica scoppia con lo schiaffo ad Aurora, che si adira per l’offesa al suo rango e poi lo sparo, la morte di lei, il processo, la condanna esemplare e tutto ritorna alla normalità, ricollocando ognuno al proprio posto.
RIFLESSIONI E CONCLUSIONI
L’autore riconferma il tacito principio secondo cui tutti sono vittime della realtà del condizionamento sociale, sia i poveri che i borghesi.
Un concetto espresso dal Principe di Salina nel romanzo “Il Gattopardo”, personaggio emblematico della conservazione del potere da parte della nobiltà, sintetizzata nella frase “Se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi”.
Armando Caltagirone si rivolge soprattutto ai giovani che non conoscono alcune importanti pagine della storia siciliana, sottolineando gli effetti secolari di quel “patriarcato tossico”- come lo ha definito Marianna La Barbera – in cui domina di fondo la convinzione mutuata dalla cultura araba secondo cui la donna sarebbe un oggetto di puro piacere e priva del diritto di scegliere.
Uno scenario di grande arretratezza in cui sono le famiglie a decidere per le figlie in materia di matrimonio.
“Tacito silenzio” è un libro attuale perché, oltre al dettagliatissimo excursus storico, ha il coraggio di mostrare quanto sia ricorrente il femminicidio nella cultura siciliana e non solo: troppe sono le storie “ordinarie” di violenza che fanno riflettere sulla continua ciclicità di delitti mascherati dall’onore leso del maschio, dalla sua insicurezza e dalla necessità di affermazione.
Non a caso, l’opera è stata presentata alla Prefettura di Agrigento in occasione della Festa della Donna.



